di Luca Ricolfi, Il Sole 24 Ore 14.6.2016
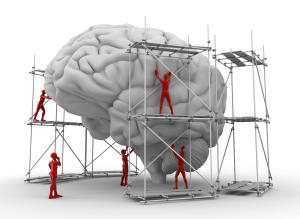
– Di disuguaglianze non si smette mai di parlare. Ci sono le disuguaglianze economiche, le disuguaglianze sociali, le disuguaglianze nella salute. Ci sono le disuguaglianze nel capitale ereditato dalla famiglia, nelle opportunità di vita, nel talento individuale. E ci sono, naturalmente, le disuguaglianze nel livello di istruzione, ossia nei titoli di studio che ognuno riesce ad aggiudicarsi.
C’è un tipo di disuguaglianze, tuttavia, che è enormemente cresciuto negli ultimi venti anni, e di cui nessuno parla. Un tipo di disuguaglianze che regala a una minoranza della popolazione una vita piena di opportunità e di soddisfazioni, mentre impone alla maggioranza un’esistenza difficile o comunque piena di limitazioni.
Di che cosa si tratta?
Non c’è un termine condiviso per designare questo tipo di disuguaglianze, ma io le osservo quotidianamente nel mio lavoro di docente universitario che da anni insegna materie relativamente complesse (analisi dei dati e matematica) e ha a che fare sia con le “matricole” (gli studenti appena diplomati che si iscrivono all’università) sia con gli studenti che stanno per laurearsi. Possiamo chiamarle, molto approssimativamente, disuguaglianze di conoscenza; oppure “disabilità cognitive”, in omaggio al lessico in voga.
È imbarazzante descriverle, perché hanno raggiunto livelli che mi verrebbe da definire umilianti, livelli che peraltro i test correnti, più o meno standardizzati, non sono assolutamente attrezzati per misurare in tutta la loro ampiezza. Devo però fare una premessa, prima di tentare una descrizione. La materia che insegno, per essere compresa e padroneggiata a un livello accettabile, richiede un discreto grado di organizzazione mentale. In buona sostanza capacità quali: padronanza della lingua, astrazione, ragionamento, manipolazione di simboli astratti, memorizzazione. È chiaro che simili capacità, come qualsiasi altra (compreso saper ballare, suonare uno strumento, o sciare in neve fresca) non possono essere possedute da tutti nella stessa misura. Il punto, però, è che quando vengono messe alla prova da un esame universitario si rivelano distribuite in un modo mostruosamente ineguale fra gli studenti. E dico questo non nel senso che ci sono studenti molto più bravi di altri (è sempre stato così), ma nel senso che, al giorno d’oggi, almeno la metà degli studenti non ha assolutamente, neppure alla lontana, la preparazione di base che – in teoria – dovrebbe possedere in virtù del certificato che esibisce (diploma di scuola secondaria superiore). Spesso non ha neppure la preparazione che ci si aspetta da chi si è fermato alla scuola media inferiore. E in un numero di casi tutt’altro che trascurabile non ha nemmeno le competenze che, sulla carta, dovrebbero essere trasmesse e garantite dalla scuola elementare (ad esempio far di conto e non compiere errori di ortografia). All’attonito docente universitario può persino accadere di trovarsi di fronte uno studente che non sa eseguire una sottrazione elementare (1-5), o non sa addizionare 12 e 8 e deve ricorrere alle dita per arrivare al risultato (naturalmente quest’ultimo è un caso-limite, ma la domanda è: come ha potuto la scuola “certificare” le sue competenze e rilasciargli un diploma?).
Per non parlare del titanico lavoro di correzione dell’italiano che incombe sui docenti quando giunge il tragico momento della tesi di laurea (o meglio di quell’esercizio che ci ostiniamo ancora a chiamare tesi). Proverò a dirlo in un modo ancora più crudo: per quel che vedo quotidianamente, una parte degli studenti universitari ha un livello di organizzazione mentale che non è, semplicemente, un po’ meno buono di quello degli studenti bravi, ma è abissalmente inferiore, come può esserlo il livello di organizzazione mentale di un bambino di sei-sette anni rispetto a quello di un adulto. E, cosa ancora più triste, in molti casi il gap appare irrimediabile, in quanto chiaramente legato a percorsi scolastici disastrosi, a occasioni di conoscenza clamorosamente mancate e che difficilmente potranno ripresentarsi. Alla fine degli esami io chiedo sempre “che scuola hai fatto?”, e le risposte che mi accade di ascoltare sono terrificanti: quello che i tanti studenti in difficoltà raccontano sugli insegnanti che hanno avuto, sul numero di supplenti che si sono alternati in certe materie, sui programmi svolti e non svolti, sulle licenze didattiche che tanti prof si sono presi, tutto questo restituisce un quadro della scuola mortificante. Un quadro, sia detto per inciso, in cui non si intravedono più, come un tempo, condizioni di svantaggio sociale, o tragedie familiari e personali, bensì solo prosaiche vicende istituzionali (e spesso familiari) di incuria e superficialità, approssimazione e leggerezza. In sostanza: l’ordinario modus vivendi di una società in cui, di fatto (anche se a parole lo neghiamo), la cultura, la conoscenza, lo studio sono divenuti assai meno importanti di tutto il resto.
Non mi interessa, qui, indicare di chi è la responsabilità, che è chiaramente di tutti: genitori, insegnanti, politici e, naturalmente, studenti (il non-studio è anche una scelta). Quello su cui vorrei attirare l’attenzione è invece l’enorme diversità di destino fra i miei studenti. Quando li incontro e quando ci parliamo, lo vedo ad occhio nudo: c’è chi quasi certamente ce la farà, perché la scuola e l’università hanno strutturato la sua mente, e c’è chi (salvo il caso in cui abbia una famiglia potente alle spalle), avrà una vita lavorativa difficile, perché la scuola e l’università hanno preferito rilasciargli un titolo senza occuparsi seriamente della sua mente. È strano. Da un paio di decenni abbiamo deciso che le nostre sono “società della conoscenza”, non c’è occasione in cui non ripetiamo che la conoscenza è la variabile fondamentale, che da essa dipendono i destini delle economie come quello degli individui; da anni e anni ci stracciamo le vesti, scendiamo in piazza, firmiamo manifesti e appelli contro la (presunta) inarrestabile crescita delle disuguaglianze economiche, e poi – chissà perché – di fronte agli spaventosi divari di conoscenza fra i nostri giovani, che certamente produrranno grandi disuguaglianze nelle loro vite, non diciamo nulla, li accettiamo come se non esistessero, o non fossero importanti. C’è qualcosa che non va. O sbaglio?
.
Se la scuola non riesce più a formare le competenze «di base» ultima modifica: 2016-06-14T06:49:37+02:00 da

